
La via di sotto
- Cristina Costantini

- Jul 20, 2025
- 4 min read
In genere tornavo per la “via di sotto”.
Era il modo semplice, efficace perché visivo, di indicare nel nostro lessico famigliare (me lo aveva insegnato zia Adele quand’ero ancora piccola) un percorso alternativo: non la strada principale, prevedibile e affollata, ma la parallela secondaria, in ombra e di certo meno trafficata. Eppure sapida di meraviglie.
Così, all’uscita dal Gabbiano (i bagni di sempre - ci sono tornata, a più riprese, per riavvolgere i nastri di questa vita ed ogni volta, lo ammetto, è stato un boomerang, una corrente di risacca verso un tempo che non è più), iniziavo a contare i passi sulla stringa di marciapiede che correva sotto la Torre Fara, bellissima e ancora sbrecciata dal vento della storia e dalla salsedine di vecchie e nuove maree. Era un po’ come sentire chi c’era stato per gioco o per dovere, per lavoro o per passione. Quasi una danza di sonnambuli, elegante e beffarda, lenta perché eterna, mentre sul ciglio opposto il passaggio di un treno merci batteva il ritmo dell’effimero con il suo fischio assordante e metallico. Poi arrivava il cantiere navale che entrava nelle narici prima che negli occhi: un misto di olio e carburante, legno e vernice; un’esposizione di scafi e impalcature, ripari d’occasione per qualche nobile gatto randagio.
Dopo poco, le vetrine di Olga, la rosticceria delle acciughe impanate e del cappon magro, della cima e dei totani ripieni, delle torte di carciofi e patate, un arcobaleno di colori e gusti accessibili, ma anche l’angolo di ristoro per un’ultima bottiglietta d’acqua o lattina prima del bivio: a destra la passeggiata a mare, a sinistra la ferrovia. L’avventura portava a misurarsi con il passaggio a livello, a volte aperto, più spesso chiuso per un tempo impredicibile, metafora di questa esistenza terrena, che allora non si conosceva ancora così.
Un attraversamento di terra, non di mare.
Dall’altra parte, la collina e la casa bella con la torre, le persiane verdi muschio e la palma del giardino: se qualcuno mi avesse chiesto allora, sì - avrei detto - da grande è lì che voglio abitare! Intanto, però, c’era un tragitto ancora da compiere per corso Buenos Aires, tra palazzi e alberi, fino al supermercato che sapeva d’anguria e melone tre isolati prima della sua insegna e il ragazzo che impilava cassette di verdura e salutava con il suo ciao abbronzato. Ci si conosceva perché l’estate era una promessa annuale sempre mantenuta e mai sbiadita. Ancora l’edicola dei fumetti e dei giochi gonfiabili, degli occhiali da sole e dei cappellini, degli stuoini (quanti zuppi e poi rotti) e delle ciabatte di gomma (non Birkenstock, non Crocs).
Li vedo ancora i miei passi e i miei occhi. Non so chi andasse più veloce. E le pulsazioni, di gioia, non d’età.
Le mattonelle a margherita, precise come le cornicette disegnate nei quaderni a quadretti, portavano in coro verso un assolo che si apriva tondo: piazza Torriglia con il suo parco e qualche gioco, umile eppure fantasioso. Poi il viale diritto e lungo prima delle palme, poi delle magnolie (lo nominavamo in ragione della specie di piante che lo contornavano, ma all’anagrafe cittadina era iscritto come Viale Arata), con la Chiesa dei Cappuccini e padre Anacleto, sempre in bicicletta con il suo saio e la sua pelle buona come il sole, mentre a guardia del convento rimaneva la statua di pietra enorme, incrollabile come la fede di chi crede davvero. Gli direi, oggi, del mio viaggio nel suo sguardo chiaro, e di mio padre che non c’è più e che tanto gli voleva bene.
Ancora isolati di case, lo studio della mia pediatra, il portone delle amiche, il cortile di una bambina incontrata per caso e non conosciuta che poi avevo rivisto proprio lì, in quella striscia di verde messa ad ornamento di un edificio giallo oro.
Poi si girava sulla sinistra in viale Millo, con le tre ville, rosa, grigia, di cotto, che facevano sognare saloni e ricevimenti, vite da grandi, musica e giradischi. Ne ho sempre preferita una diversa: d’infanzia la rosa; in adolescenza quella in cotto (aveva una torretta e una finestra circolare che, pensavo, è l’oblò del mio studio di scrittura); durante il liceo quella grigia (aveva un che di diplomatico).
Le ho riviste e le ho rivissute. L’ultima volta tutte insieme, senza gerarchia per comporre dentro le mie voci ed accordarle ai miei ricordi.
Quindi il parco sull’angolo con le altalene e gli scivoli e davanti il baretto sempre aperto dove rimediare un cartone di latte quando tutto il resto era chiuso. A lato, all’inizio del caruggio, Jacopetti, il negozio di lampade, luci, lampadine che per zia era la soluzione magica di ogni male (quando crebbi, lei mi disse, anche per computer ed elettronica, ma non era vero).
Poi Mercati, la salumeria- gastronomia che non c’è più, e il profumo denso di focacce, pomodori, peperoni, albicocche e pesche che ti prendeva sottobraccio per portarti a casa.
Si perché all’angolo, di nuovo sulla sinistra, c’era la strada che iniziava a salire e portava ad un sogno fatto realtà.
E ancora, dopo mezzo secolo giusto, non è colpa di nessuno se la mia pelle bianca e nuda si veste di quei sapori e così inizia il suo nuovo giorno.
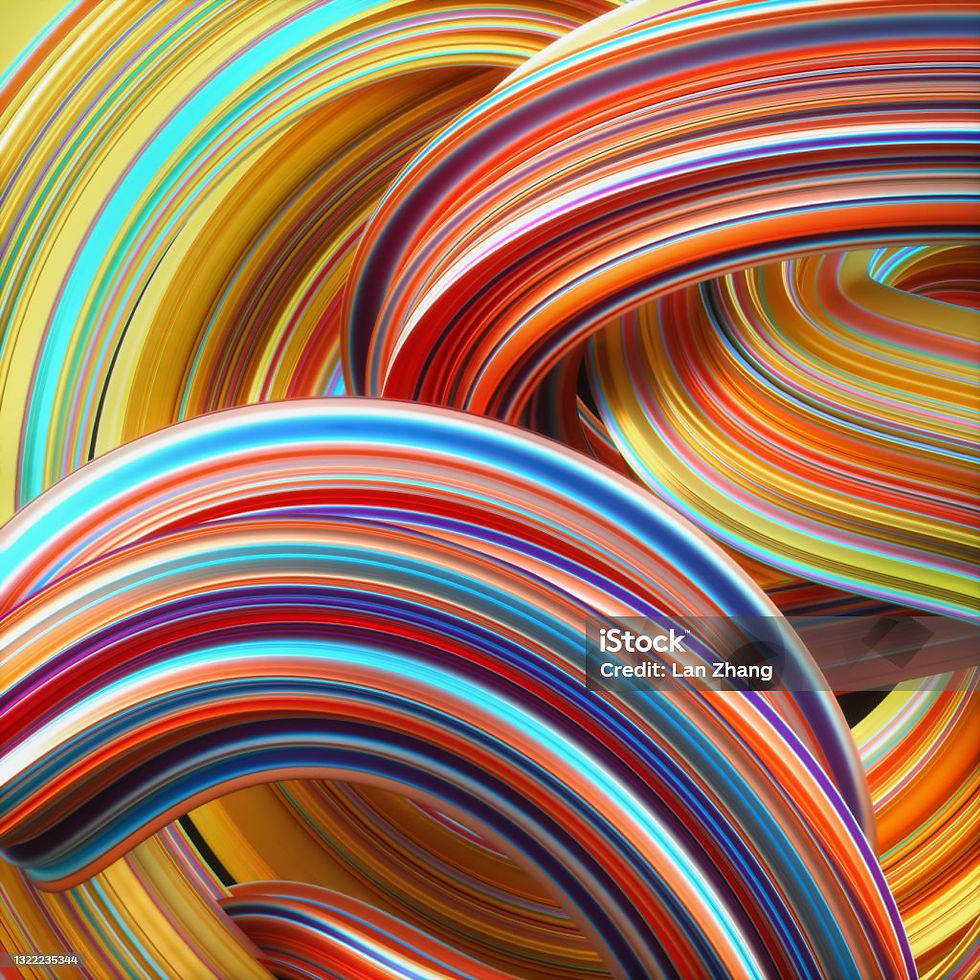

Comments