Si chiamava Francesco
- Cristina Costantini

- Apr 25, 2021
- 3 min read

Si chiamava Francesco.
Aveva i capelli fulvi, un regalo ricevuto dal padre alla nascita, un’investitura bizzarra in un clan famigliare che del bruno scuro aveva fatto il suo contrassegno. Era cresciuto all’ombra delle Alpi carniche, protetto dal loro abbraccio malsicuro, eppure così naturale da desiderarlo ogni volta, quando i terremoti dell’infanzia e dell’adolescenza sembravano più forti da sopportare. Di quelle montagne, conosciute per nome, aveva sentito le storie tramandate da generazioni con la gentilezza della fantasia. Se tutto intorno scuoteva e tremava, era per la ritrosia della Marianna (La Mariane, nella lingua parlata dai nonni) che si scherniva non volendo cedere al corteggiamento del poderoso Simeone. In quel mondo, fatto di colori intensi e linee dure, anche la paura poteva generare amore.
Per amore, Francesco aveva dato cuore e braccia ai suoi genitori, umili e fieri, silenziosi perché incapaci di misurare il tempo a parole. Aveva corso chilometri in bicicletta, prendendo sassi e buche, ma salvando sempre il carico in consegna che gli era stato affidato. Viveva del verde roccioso che univa Gemona a Tolmezzo e lì, tra crepacci e arbusti, aveva nascosto i propri sogni. In ogni piega del crinale vegliava il suo futuro, quello bello, quello che la giovinezza sente possibile, pieno e tondo, tanto da fermare a tratti il respiro.
Era innamorato del nome del suo paese, Trasaghis, e lo ripeteva insieme ad Avasinis, Peonis, Braulins, fino a comporre una musica tutta sua, accordata su un pentagramma di saggezza antica insieme alle note con cui Antonio, il padre, faceva parlare il proprio violino. Non pensava di lasciare quella terra, anzi, si vedeva, semplicemente appagato, a pescare frutti di vita sulle rive del lago di Cavazzo o lungo la sponda brulla del Tagliamento.
Intanto gli anni trascorrevano, come il flusso del fiume, al di là del quale si appostava l’inganno teso dal destino. Cresceva insidioso, dietro un’ansa che, con strazio materno, Elvira avrebbe percorso ogni sera, per riprendersi ciò che le era stato violentemente rubato.
Francesco era diventato un giovane uomo, saldo e robusto. Aveva studiato e si era diplomato, pronto a progettare e costruire case, a riprendere dalla nicchia montana, che l’aveva fino ad allora custodita, la propria speranza per farla abitare in una nuova dimora spaziosa e alta, perché gioia ed onestà non potevano limitarsi ad un solo piano.
Aveva trovato lavoro e lo spazio tra alba e tramonto era scandito dai turni del suo impegno. Non si era ancora fidanzato, anche se si sentivano battiti intorno.
Poi arrivò il ‘39. Le montagne smisero di parlare e di confessarsi i loro segreti amori. Era guerra.
Francesco partì, soldato semplice della Brigata Julia. Lasciò il suo mondo e annegò nel fondo del lago l’azzurro trasparente del suo sguardo. Insieme a tanti altri era stato chiamato. Per l’Italia, per la Patria.
Da lontano continuò a scrivere, appena possibile, in postazioni di fortuna, in bella grafia, come gli piaceva, per ripetere ancora quel senso di buona possibilità che gli scorreva nel sangue e lo dissetava come un sorso limpido del suo Tagliamento.
Un giorno ai suoi giunse una lettera, lunga, intensa. Francesco chiedeva di interessarsi per il suo lavoro, perché tutto fosse in regola per poter riprendere con correttezza al suo ritorno. Domandava notizie della famiglia, figlio devoto, fratello premuroso. Raccontava, ancora, di una battaglia imminente, quella che si sarebbe rilevata importante, decisiva e con tutto l’ardore dei suoi vent’anni chiudeva così: “Domani sarà l’alba di una radiosa vittoria!”.
Era alle porte di Nikolajewka.
Le lettere che avrebbe continuato a scrivere rimasero imprigionate nel ghiaccio sovietico. Le sue orme affondate si sono perdute.
Le vedo per un pezzo, che cercano la via per la Carnia e poi si arrestano.
Intorno solo bianco. Bianco puro, come lui.
Si chiamava Francesco ed era mio zio.
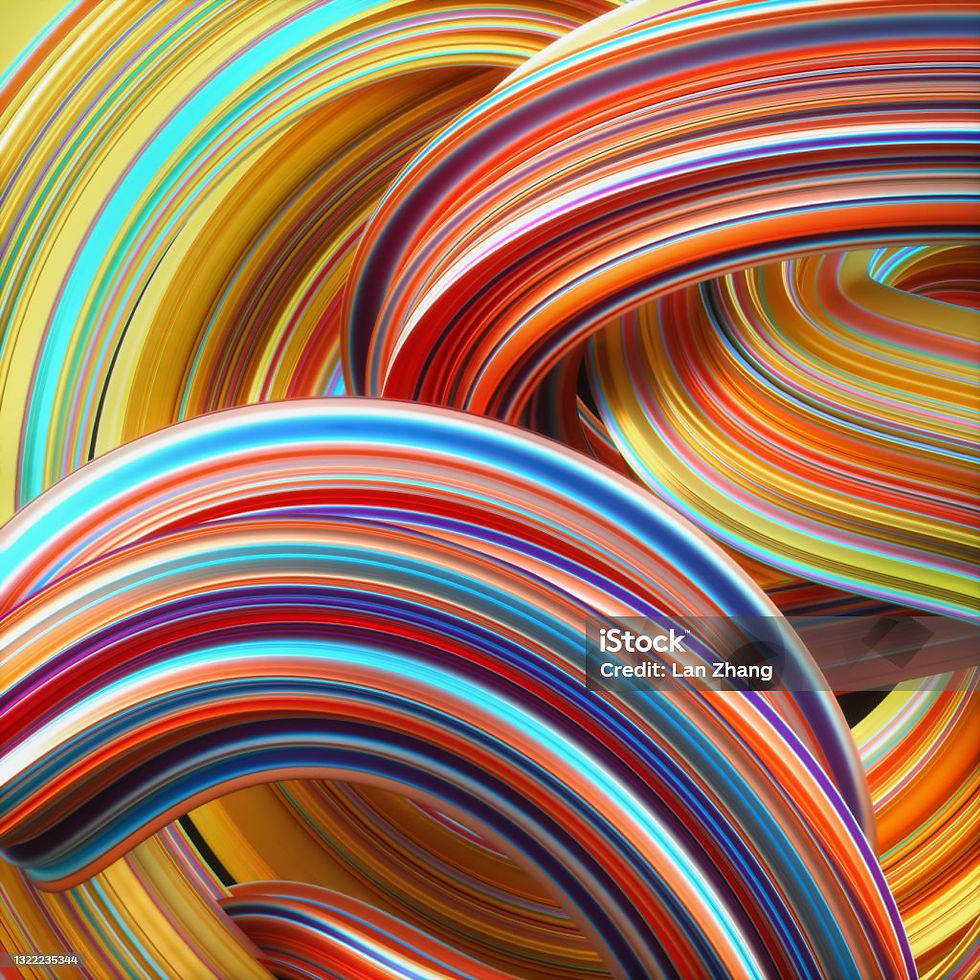

Comments